|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
E' ampiamente documentato
che, intorno ai primi decenni del Cinquecento, la città di Napoli,
la capitale, esercita una forte attrazione sulla nobiltà delle
province del Mezzogiorno, che comincia a trasferirsi provocando anche,
con questo processo di inurbamento, una notevole lievitazione dei prezzi
delle abitazioni.
Tra il 1512 e il 1513, tra
i cantieri per palazzi e residenze signorili, si costruisce a cura
dell'architetto
cosentino Giovanni Donadio, detto il Mormando, completamente rifacendo
e ampliando una costruzione già esistente, l'imponente palazzo
di Bartolomeo di Capua, principe della Riccia, conte di Altavilla (passato
poi ai Marigliano del Monte nella seconda metà dell'800).
Questo palazzo, tuttora privato,
secondo Roberto Pane "vanta la pi elegante facciata rinascimentale
di Napoli, anche se le sale interne non conservano quasi nulla della
primitiva forma, perché rifatto in età barocca".
|
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
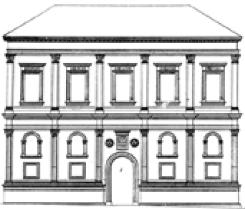 |
|
 |
|
 |
|
1 - Part. Mappa del
Baratta - sec. XVII
2 - Prospetto di Palazzo Marigliano - sec. XVI
|
|
 |
|
Il palazzo, oggi noto come
Palazzo Marigliano, si affaccia sul decumano inferiore greco-romano,
confermando ancora nel sec. XVI la predilezione della nobiltà napoletana
ad insediarsi nel centro antico, come era già avvenuto
nei sessant'anni di regno aragonese, contro la tendenza angioina che
aveva attratto intorno alla corte in Castelnuovo un nuovo quartiere
patrizio.
Con Pedro de Toledo verrà
a cessare ancora questa predilezione per l'antico centro, con l'apertura
della nuova strada, Toledo appunto, seguita successivamente dall'urbanizzazione
di Pizzofalcone prima e della Chiaja poi. Per alcuni secoli si perse
la memoria dell'autore di palazzo de Capua, il Mormando, mentre il palazzo
veniva menzionato solo di sfuggita (per esempio dal Celano), e, fino
alla metà dell'800, pur citandosi il palazzo e la famiglia del
suo possessore, se ne faceva erroneamente attribuzione ad altro architetto.
La giusta attribuzione al Mormando fu merito di Bartolomeo Capasso che
nel '900 poteva confermare l'esatta paternità, già attribuita
al Mormando da qualche studioso per motivi stilistici, attraverso un
documento d'archivio con cui gli eletti della città concedevano
la licenza a Bartolomeo di Capua "... secondo lo disegno età consiglio
de mastro Johann Mormando architetto".
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
3 - Part. del frontale su Via San Biagio; 4 - Part. dell'ingresso nel cortile;
5 - Part. dell'affresco di De Mura nel Salone
|
 |
|
La facciata del palazzo originario,
pur condizionata dalla stretta strada, era nella sua eleganza rinascimentale
caratterizzata dalla sovrapposizione degli ordini architettonici su
un alto basamento rettilineo in piperno, oggi compromesso dall'apertura
di alcune botteghe e dalla manomissione del portale, che era costruito
da un'arcata trionfale tra le due colonne ioniche, tipicamente 'mormandeo'
come quelli di via Tribunali 231, via San Giovanni Maggiore Pignatelli
29, e nel cortile del palazzo del Panormita a via Nilo. Per quanto riguarda
gli interni, il cortile con la scala a doppia rampa che termina in una
esedra neoclassica e il giardino pensile, gli interventi di restauro
sono del 1759, nel venticinquesimo anno di regno di Carlo di Borbone,
ad opera di un altro Bartolomeo di Capua, ventesimo conte di Altavilla,
come si leggeva in una epigrafe eliminata nel passaggio ai Marigliano
che acquistarono il palazzo nella metà del secolo scorso. Oltre
al valore architettonico il palazzo desta un grande interesse anche
dal punto delle vicende storiche. Entrando nel maestoso portone, nell'atrio
che immette al grande cortile, si leggono ai due lati su lapidi murarie
ora molto scolorite, due iscrizioni sulle panchine di pietra (molto
danneggiate e private degli appoggi laterali).
La prima a sinistra richiama
il ricordo di Costanza di Chiaromonte, che sposò a Gaeta Ladislao
di Durazzo, incoronato re durante le nozze stesse, che fu ripudiata
dopo due anni perché la madre, vedova di Manfredi di Chiaromonte,
a Palermo conduceva vita dissoluta. Poi Costanza era andata sposa sempre
a Gaeta ad Andrea de Capua e aveva quindi vissuto nel palazzo nel sec.
XV, quindi prima della sua riedificazione del 1513.
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
QUESTO PALAZZO NEL SECOLO XV
APPARTENNE AI DE CAPUA
E VI VISSE
COSTANZA DI CHIAROMONTE
REGINA DI NAPOLI
MOGLIE DI ANDREA DE CAPUA
GRAN CONTE DI ALTAVILLA
GRAN PROTONOTARIO DEL REGNO.
ULTIMO DI SUA STIRPE IL PRINCIPE BARTOLOMEO
SALVO' RE CARLO III ALLA BATTAGLIA DI
VELLETRI
LO STORICO EDIFICIO CON AFFRESCHI DEL DE MURA.
EBBE NUOVO SPLENDORE DI VITA
ED ATTRAVERSO LE RUINE DELLA GUERRA,
I MARIGLIANO DEL MONTE NE CUSTODIRONO
IL GELOSO RETAGGIO.
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Nella seconda lapide, a destra
nell'atrio, si legge che nel 1701 vi congiurarono con Tiberio Carafa
i nobili de Sangro, Capace, Gambacorta col principe della Riccia, che dettero
vita alla Congiura antispagnola di Macchia (ma l'episodio della
presenza dei congiurati nel palazzo sembra privo di storicità).Il
Carafa, esiliato a Vienna dal governo vicereale, fu reintegrato nei
feudi da Carlo d'Austria e mai accettò
|
|
 |
|
come suo re Carlo di Borbone.
Nell'affresco della volta
del Salone delle Feste il De Mura, intorno al 1750, dipinse la battaglia
di Velletri, in cui fu ferito anche il principe della Riccia, con l'episodio
del giovane Sanseverino che fa scudo a Carlo di Borbone perdendo la
vita per offrirgli il suo cavallo, col quale Carlo superò il
nemico e giunse a Napoli col suo esercito. Nel 1942 l'affresco fu bombardato
e nel 1950 il duca di Marigliano, proprietario in quegli anni, lo fece
restaurare e ricostruire (ne restava solo la parte occidentale) e vi
fece scrivere su un lungo cartiglio (con molte inesattezze) il ricordo
della Congiura collegandolo alla vicenda risorgimentale, dunque con
una superficiale commistione tra Borbone e Savoia.
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Con l'estinguersi dei de Capua, l'ultimo erede aveva stabilito di fare acquisire il nome al secondo figlio di un Sanseverino di Bisognano, conte della Saponara. Questi, riparati molti debiti, pur non potendo accedere alla successione feudale,
accettava di far precedere al suo nome quello dei de Capua, ma non trovava successione di eredi del figlio morto giovane e vendeva il palazzo ad un suo cugino, Francesco Saverio Marigliano, duca del Monte.
La Soprintendenza
Archivistica per la Campania, Istituto del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, che occupa parte del palazzo, è fortemente impegnata
alla valorizzazione di palazzo Marigliano che con la sua iscrizione
"MEMINI" che si ripete sui frontali delle finestre e sull'arco
di marmo dello scalone, esorta alla conservazione e al massimo
rispetto
della memoria per costruire, con la lezione delle vicende del passato,
un consapevole futuro.
Maggio 1996
Torna a inizio pagina
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |